L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Juliet Anno Numero 97 Aprile 2000
L'arte dallo psicoanalista
A cura di Luciano Marucci
4° puntata, continua
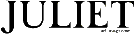
Art magazine
Adrian Paci
Maria Vinella
n. 173 giugno-luglio 2015
Case chiuse, corpi aperti
Roberto Borghi
n. 172 aprile-maggio 2015
Yang Xinguang e la materia
Sara Bortoletto
n. 171 febbraio-marzo 2015
Eugenio Re Rebaudengo
Giulia Bortoluzzi
n. 170 dicembre-gennaio 2015
Biennale Architecture
Gabriele Pitacco Marco Gnesda
n. 169 ottobre-novembre 2014
Biennale Marrakech
Emanuele Magri
n. 168 giugno-luglio 2014

Con l'aiuto del professor Mauro Mancia continuiamo l'esplorazione (iniziata nell'ottobre scorso) dei fenomeni legati alla rappresentazione artistica e all'interpretazione dell'opera nel momento in cui si va tracciando un bilancio su teoria e pratica della psicoanalisi. Ciò nella consapevolezza che nel secolo appena archiviato l'individuo, nel tentativo di rendere accessibile l'inconscio, abbia acquisito una più profonda autoconoscenza anche in rapporto al mondo. Nonostante le trasformazioni subite dalla disciplina, resta innegabile la sua relazione dialettica con le altre culture umane e la promozione del metodo scientifico applicato alla sfera del sapere.
Professor Mancia, in quali casi la psicoanalisi può dare il migliore contributo alla lettura della produzione artistica?
La psicoanalisi può dare l'interpretazione a qualsiasi opera d'arte che funziona solo se ha la possibilità di mettere in moto il gioco di oscillazione. Simbolo e inconscio sono dappertutto. Breton pensava che la psicoanalisi fosse particolarmente interessata al Surrealismo, invece sappiamo che Freud non era molto attratto dalle sollecitazioni di Breton. Oggi noi lo siamo di più, però, guardiamo a tutte le rappresentazioni, non soltanto a quelle dei surrealisti che ci costringono a un maggiore lavoro relativamente ai simboli, a determinati oggetti e quindi al significato simbolico della composizione. Tutte le opere d'arte hanno aspetti che interessano gli psicoanalisti senza arrivare all'interpretazione che ha dato Freud di Leonardo, né a quella di Fornari sulla "Tempesta" di Giorgione. Sono tipi di letture che non condivido, soprattutto quando Fornari parla del padre militare che difende la figura della relazione madre-bambino. Io sono attento a quello che succede nello spettatore di fronte a un'opera d'arte, piuttosto che a un'analisi dell'opera stessa.
Ma, per accedere a questo particolare mondo, bisogna essere bene informati...
Purtroppo molti psicoanalisti non seguono le arti. Vedo pochissimi colleghi alla Scala e alle mostre...
Dopo le esperienze degli anni Settanta, per la verità acerbe rispetto a quelle teatrali, il ritorno al linguaggio del corpo cosa può significare?
Facevano parte di una tendenza culturale. A suo tempo mi sono occupato della Body Art. Nel 1976 scrissi un articolo, per la rivista "Data" di Tommaso Trini, sulle capacità di quella corrente, rispetto ad altre di quel momento storico, di mettere in moto il nostro mondo interno. Mi aveva colpito anche uno spettacolo teatrale a Venezia con Eugenio Barba. È come se negli anni Sessanta avessimo raggiunto un plateau, una stabilità, soprattutto in Europa, per cui tutto sembrava ristagnare. La relazione tra il fruitore e l'artista era scontata e spesso noiosa. Chi ha riportato un po' di vivacità? Il gruppo del Nouveau Realisme francese e poi gli americani, soprattutto quelli che abbiamo conosciuto attraverso la collezione Panza di Biumo. Non bisogna dimenticare Kassel, che io ho seguito in ogni edizione tranne l'ultima. A questo punto l'arte corporale è arrivata proprio come una sferzata, con le rappresentazioni più violente e di attacco alla sessualità. Ricordo quando Hermann Nitsch "squartava" animali nella Galleria Out Off di Milano e faceva in modo che quelle viscere fumanti e piene di feci cadessero sui genitali di una donna o di un uomo nudi distesi sotto l'animale appeso. C'era un attacco frontale, totale, feroce, violento alla normalità, alla genitalità, all'uomo, alla sua creatività. Quando 'officiava' con una grande tunica bianca che si macchiava di sangue mentre tagliava il ventre degli animali, le viscere scendevano e i suoi amici fischiavano violentemente al punto di assordare; si creava un'atmosfera di tale provocazione, di violenta intrusione all'interno di noi che non poteva che destabilizzarci. Molta gente se ne andava dimostrando di non accettare la provocazione, oppure rimaneva - come facevo io - soffrendo rispetto a quel messaggio che dovevo poi valutare, filtrare, rielaborare in maniera da ricostruire dei miei valori che erano quelli della sessualità, della creatività e della relazione. In tal senso l'arte corporale ha avuto una funzione e la psicoanalisi mi ha permesso di valutare il mio "contro-transfert" rispetto a quella rappresentazione per poter metabolizzare lo stress, lo shock che io in gran parte rifiutavo ma che, in altra parte, dovevo accettare per trasformarlo.
La riscoperta del corpo, incoraggiata da Jean Clair con la Biennale di Venezia del '95, non è soltanto un fatto fisico ed ha anche un senso antropologico.
È la valorizzazione del fisico rispetto alle idee, all'immaginazione. Come uomini, sul piano mentale, siamo continuamente oscillanti tra l'uno e l'altro mondo. Lo vediamo anche nella patologia: individui che sviluppano deliri e che fisicamente stanno bene; individui che per difendersi dai deliri sviluppano malattie psicosomatiche, per cui stanno bene dal punto di vista mentale e male nel corpo. Il rapporto stretto che esiste tra corpo e mente ha le sue radici nell'infanzia. Per capire il problema, dobbiamo rifarci alle primissime esperienze del bambino, quando, prima della nascita e dopo, è a contatto con la madre attraverso la sensorialità. Il modo come la madre lo tiene, lo allatta, gli parla, lo guarda, gli odori che ella ha sulla pelle... sono tutti elementi attraverso i quali veicola il proprio affetto al figlio che così è in grado di crearsi le prime rappresentazioni affettive. Sta qui il nucleo centrale da cui partiranno i processi trasformativi, a cominciare dalle imitazioni, per seguitare con le identificazioni proiettive ed introiettive, quindi con la simbolizzazione, col pensiero. È tutta una catena progressiva i cui anelli terminali apparentemente non hanno più a che fare con il corpo. L'arte corporale ci riporta bruscamente a queste prime esperienze e, quindi, è in grado di costringerci a rifare il percorso a ritroso e ci permette di rivivere l'esperienza.
Tra l'altro, eliminando il diaframma dei media linguistici, si ha una comunicazione più diretta e sincera, sebbene il gesto venga teatralizzato.
Quando il corpo è coinvolto, il problema della comunicazione, della drammatizzazione è affidato tutto a esso.
L'arte corporale, in un certo senso, ci riporta al significativo caso di Bacon.
Apparentemente egli non visse il corpo, ma la sua immagine deformata, distorta, sofferente, vomitante; forse una realtà che non accettava. Quindi, dava la rappresentazione iconica della sua parte di personalità più disturbata e sofferente, psicotica. Era in sintonia con un altro personaggio interessante, Lucien Freud, anch'egli con scelte omosessuali particolarmente violente. In loro prevalgono parti narcisistiche molto autarchiche, al limite del delirio. E la loro parte più creativa è in grado di coglierle, di "usarle" rappresentando la sofferenza personale che è anche quella univesale.
Avrai seguito da vicino pure il lavoro dello sciamano Beuys?
In varie occasioni, compresa Documenta di Kassel di tanti anni fa. Di lui mi interessava la concentrazione. In fondo ha lasciato poche opere concrete rispetto alla densità di pensiero. Era più un ambasciatore di idee che di oggetti e sapeva comunicarle con il gesto, un po' come Bob Wilson, il quale, a parte le regie e altre cose, nel teatro è minimalista. Può passare tre ore in palcoscenico stando in silenzio e facendo solo piccoli movimenti. La sua è un'arte del corpo straordinaria che veicola affetti, emozioni, sentimenti capaci di destabilizzare. Negli anni Settanta ho assistito a una delle sue prime performance al Teatro Manzoni di Milano. Era una domenica mattina, tanti bravi borghesi erano arrivati felici di vedere questo genio del teatro, senza immaginare di trovarsi di fronte a uno che per due ore si muoveva appena senza parlare mai. Dopo un po' alcuni si sono alzati e se ne sono andati rompendo il silenzio con il rumore delle poltrone. Se avessero avuto la costanza di restare, si sarebbero accorti che lo spettacolo sollecitava una quantità di pensieri, di problemi ed era quello il messaggio che l'artista voleva comunicare.
L'esperienza di Beuys è stata fondamentale per promuovere la nuova creatività... Egli diceva (e dimostrava) che il pensiero non ha limiti. Riconosceva all'immaginario un ruolo primario per il progresso di un mondo senza divisioni ("La rivoluzione siamo Noi" / "Kunst = Kapital"); al contrario, predicava i limiti dell'economia capitalistica. Come sai, la sua azione non si fermava all'oggetto estetico: usava la parola, la lavagna, le forme simboliche per plasmare la "social sculpture". Con le sue capacità alchemiche e la visione romantica riusciva a far espandere il sublime nella realtà. Con grande tensione morale sapeva concentrare nell'opera le intenzioni artistico-ideologiche; imprimere energia vitale alle diverse componenti investendole di spiritualità.
Ma voleva anche mettere in crisi la stabilità interna degli spettatori. Era un sano provocatore, mentre Nitsch, per esempio, esasperava gli istinti più sadici. Di Beuys è impossibile dire tutto. Io credo che avesse un pensiero ideologico molto forte, di tipo umanitario. Quell'insieme di slitte, quasi da croce rossa, portate a Kassel, in questo senso davano una comunicazione efficace.
Stai parlando della "Mandria". Riguardava la possibilità dell'uomo di aiutare l'altro. Riconduceva alla sua biografia, quando si ritrovò ferito tra le nevi e fu salvato con il feltro e il grasso.
Torniamo a dire che tutto è autobiografico. Il che dimostra che ogni uomo ha la possibilità di rappresentare in maniera del tutto particolare il suo mondo interno con i traumi e le conflittualità.
Un altro personaggio che si proietta dichiaratamente nell'opera con risultati di straordinaria intensità è la Bourgeois.
Purtroppo non conosco bene la sua biografia, ma credo che nella vita abbia avuto grossi problemi. A giudicare dalle opere che ho visto nella sala dell'ultima Biennale di Venezia, in quegli esseri racconciati, ricuciti, un po' gonfi come se fossero morti di annegamento, tragicamente sofferenti, pieni di ferite, in preda alle forze della natura, mi è sembrato di cogliere aspetti infantili, adolescenziali della sua personalità traumatizzata.
È un'artista di grande sensibilità. I suoi fantocci di stoffa, rosata come la pelle, sono esseri deformi, mutilati, doloranti. Angosciano, coinvolgendo psicologicamente. Quei corpi, tra il reale e il surreale, testimoniano crudeltà. Attraverso le loro ferite raccontano le ingiustizie umane; le lacerazioni delle memorie profonde dell'artista che, identificandosi nell'opera, le proietta nel presente che ripete la storia. Il suo lavoro è inteso come "necessità" per la vita. Anzi, è composto di "forme di vita" capaci di esprimere gioia di vivere e, a un tempo, disperazione della morte. La Bourgeois segue l' "istinto" personale, senza aderire a tendenze. Nonostante l'età, riesce a realizzare installazioni linguisticamente attuali e fortemente emozionate. Ogni volta sorprende grazie al suo messaggio di verità che riesce a far penetrare, con inquietante senso materno, nelle coscienze degli individui.
Direi che proprio in virtù dell'età rappresenta qualcosa che l'ha tormentata a lungo. I lavori di Venezia mi hanno colpito per il senso di abbandono, di tragedia. Proiettivamente rappresentano e si identificano con le parti sofferenti e mortifere di una personalità. Ed è questo il motivo che li rende vitalistici.
Dalla conversazione non possiamo escludere Basquiat, riproposto l'estate scorsa dal Museo Revoltella di Trieste e da Achille Bonito Oliva a Venezia. È un caso esemplare di indipendenza dal sistema. Riflette il disagio esistenziale di quanti si trovano a vivere in una metropoli globalizzante senza riuscire ad adattarsi ai modelli convenzionali. E la ribellione è espressa con linguaggio nativo, selvaggio. L'opera è un diagramma di segni-scritture, di graffi di rabbia che parlano del suo difficile rapporto col mondo esterno. Del resto in tutti i graffitisti c'è l'incontenibile bisogno di comunicare le angosce invadendo gli spazi pubblici.
Non c'è dubbio che in Basquiat, come in Keith Haring, ci fossero anime di individui strutturalmente emarginati che amavano vivere nei sotterranei, nei metro, e lì rappresentare il loro mondo. Non è casuale che volessero invadere lo spazio pubblico, come per entrare con prepotenza all'interno di un contesto sociale e relazionale che li aveva espulsi e che invece intendevano assolutamente possedere.
Secondo te in questo atteggiamento c'è più attacco o difesa?
È difficile distinguere; ogni attacco può essere una difesa. Sono facce di una stessa medaglia. Se ci si sente espulsi dalla società e, comunque, da quella capitalistica che non permette loro di vivere, è chiaro che si diventa aggressivi e la si attacca in modo né diplomatico né politico, ma tendenzialmente rivoluzionario. Tra loro e la società c'è una asimmetria tale che li esaspera. Denunciano così un disagio che non è solo personale, ma di tanti poveri che vivono ai margini. Per questo hanno trovato un consenso. Ognuno sente il debito morale nei confronti di individui che conducono una vita drammatica, sofferente che noi non vorremmo vivere. Anche nei più egoisti rimane un nucleo etico che permette di identificarsi con le persone in difficoltà.
Da qui anche l'attrazione per certe opere...
E la volontà di sostenere l'azione degli autori. Ricordo un convegno in cui ero stato chiamato come relatore. Sull'invito era riprodotto un grande quadro di Haring. In quella platea di ricchi borghesi iniziai a parlare facendo i complimenti all'organizzatore per aver colto il conflitto con la rappresentazione dell'artista americano che in qualche modo indicava una lontananza, una opposizione, una lievità.


