L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Juliet Anno Numero 96 febbraio 2000
La parola come ombra dello sguardo
Domenico Papa
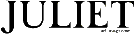
Art magazine
Adrian Paci
Maria Vinella
n. 173 giugno-luglio 2015
Case chiuse, corpi aperti
Roberto Borghi
n. 172 aprile-maggio 2015
Yang Xinguang e la materia
Sara Bortoletto
n. 171 febbraio-marzo 2015
Eugenio Re Rebaudengo
Giulia Bortoluzzi
n. 170 dicembre-gennaio 2015
Biennale Architecture
Gabriele Pitacco Marco Gnesda
n. 169 ottobre-novembre 2014
Biennale Marrakech
Emanuele Magri
n. 168 giugno-luglio 2014
Voi udivate il suono delle parole, ma non vedevate alcuna immagine; vi era solo una voce (Deuteronomio 4,12)
La rivelazione, nella tradizione ebraica si rivolge all'orecchio più che all'occhio. È un evento acustico, un suono che dispiegandosi manifesta il divino nello spazio dell'uomo. Una voce, nella sua essenza indecifrabile, ha dato origine al Creato: luce e aria ebbero a esistere solo quando furono per la prima volta nominate.
A differenza della numerosa schiera dei demiurghi delle più remote antichità, artefici di rozzi universi plasmati con una materia renitente, il Dio degli ebrei non ha che da pronunciare il mondo affinché esso esista e sempre solo con la voce lo completa dotandolo di tutto.
In origine, la voce divina era tutta concentrata in sé stessa. Prima di tutti i tempi, non esisteva altro che Dio e il suo nome: silenzio e null'altro. All'inizio del tempo, la voce ha preso a estendersi, come un soffio, articolandosi nelle molteplici forme della creazione. Il respiro contratto, la vertigine negativa di ogni suono, è infatti il Nome, un'essenza inaudita e impronunciabile che dice e produce. La parola creatrice irrompe nella vita dell'individuo istituendo una frattura (1). Se la parola dell'augure o dell'indovino è usata per predire, ammonire e consigliare, innestandosi nelle minute vicende del consultante, nella tradizione ebraica, la voce di Dio non attende l'interrogazione, ma la genera. Di qui l'abitudine all'interpretazione che in ogni parola indaga un significato di volta in volta più vero. Ma di che materia son fatte le parole?
L'alfabeto delle civiltà semitiche era un alfabeto essenzialmente consonantico, cioè un alfabeto che non prevedeva la notazione esplicita delle vocali. Lo scrivano lavorava con le sole radici di una parola e ogni radice, potendosi sempre completare nella lettura, consentiva una pluralità di significati. La comprensione di un testo derivava perciò non dalla sequenza delle lettere nella frase, ma dal controllo continuo dell'intero contesto. Ogni parola, prima di esser letta, andava collocata in un ambito di senso (2).
La lettura, negli alfabeti consonantici, era un esercizio da affrontare con estrema cautela. Leggere, significava leggere con la voce, prestare a Dio la propria lingua. La notazione delle vocali insieme a molti secoli di abitudine alla scrittura permisero l'astrazione necessaria per leggere senza dover pronunciare ciò che si leggeva. La tradizione che privilegia il suono e la parola è la tradizione di un popolo che rinnega le immagini scolpite nel legno e nella pietra. In fuga dalle civiltà che nella stabilità della materia riponevano una speranza di verità e di vita eterna, esso dichiara per sempre la propria ostilità a ogni rappresentazione. L'unico bagaglio indispensabile è il racconto e la memoria che assicura l'identità all'individuo, iscrivendola in una discendenza. Sul paradigma della genealogia che raccoglie e trasmette la tradizione sono, infatti, costruiti tutti i saperi. La tradizione propriamente rivela, secondo un liso calembour, scopre e nuovamente ricopre. La funzione della parola è, perciò, nel dissimulare: il riporre, infatti, il significato sotto strati di senso, lo preserva da un consumo indiscriminato e attribuisce una profondità al discorso. Da ciò l'aspetto esoterico di un testo contrapposto sempre a una interpretazione immediatamente essoterica. Ciò che fa mostra di sé, che si ostenta ponendosi dinanzi agli occhi in tutta evidenza, non può che sviare la mente e perderla. L'immagine, infatti, permette che emerga alla superficie ogni contenuto, anzi la superficie è il luogo proprio dell'immagine.
La superficie, soprattutto quando è mimesis, cattura l'occhio prima che il pensiero, e spesso è costruita per ingannare. L'immagine inoltre, non ha bisogno di tradizioni: si può dire riuscita se il suo significato è evidente anche all'incolto e al bambino. Libera l'osservatore dalla necessità della memoria e dall'esercizio della domanda. Essa si offre intera a chi l'osserva: perciò è sempre impudica e spesso sacrilega. L'immagine intrattiene rapporti privilegiati con il luogo che la ospita. Collocata all'interno di un tempio o di un palazzo, lo abita, predilige cioè, la geografia della conoscenza alla sua storia. Dall'immagine basta allontanarsi, anche di poco, per far sì che esca dal proprio campo visivo. Per non vedere basta chiudere le palpebre. La parola, invece, non lascia libertà: irrompe nello spazio uditivo e coglie di sorpresa, fissa definitivamente un prima e un dopo. A nulla serve fuggire dal luogo in cui la Voce è stata udita, la si potrebbe udire dovunque, anche nell'intimità del proprio giaciglio o durante il sonno.
Ogni parola vorrei penetrare con lo sguardo (Sofocle, Edipo re)
L'alfabeto greco, pur prendendo i segni a prestito dai fenici, conserva il nome e l'ordine semitico delle lettere, ma i greci attribuirono al linguaggio e alla scrittura una natura originale, maggiormente mondana, e a tal scopo operarono la trasformazione di alcune notazioni che indicavano suoni in vocali vere e proprie. L'aleph, sincope glottale, divenne alpha, la vocale a. In questo modo la lingua potè adattarsi pienamente al linguaggio e, perdendo la sua funzione sacrale, potè conformarsi alle esigenze di una nuova cultura.
Nella scrittura propriamente alfabetica, nulla di più di quanto vi è depositato va letto, mentre il lettore non è tenuto a ripetere un atto originario, ma a seguire un percorso lineare che altri prima di lui hanno tracciato. Non deve ricucire il testo con le sue parti assenti, ma tenersi nel solco della concatenazione delle parole. Comprendere significa ancora interpretare, ma ormai l'esercizio dell'intrepretazione si colloca su un piano diverso da quello frammentario degli interstizi tra le lettere. Con un alfabeto in grado di notare ogni suono, l'atto della lettura può volgersi a indagare i possibili orizzonti di senso dell'intera scrittura. Per leggere, con gli alfabeti consonantici, era necessaria una conoscenza tradizionale e sapienziale; qui, invece, l'interpretazione libera le potenzialità poietiche delle immagini che procedono dal testo. Nuova caratteristica del linguaggio è, infatti, quella della produzione di metafore e la scelta, perciò, non è più tra letture più o meno corrette, ma tra un significato letterale e le plurivoche evocazioni figurali. Un linguaggio propriamente sapienziale mette in relazione due condizioni di realtà sostanzialmente differenti, quella umana e quella ultraterrena, mentre il linguaggio metaforico, mette in relazione aspetti diversi della stessa realtà. Metaphorein è propriamente uno spostamento di qualità tra due termini, uno proprio e uno figurato, in una nuova configurazione.
Il suono della parola, nella cultura greca, non nasconde verità rivelate, ma più spesso riporta il racconto oscuro, il vaticinio enigmatico, la predizione imperfetta, l'epitteto irriverente e lo sberleffo dionisiaco. Parlano, perciò, gli iniziati, gli oracoli, gli auguri, la pizia, il guaritore e il retore della pubblica piazza, mentre gli dei, sembrano compiacersi di apparire, anche sotto spoglie stravaganti, e mentono con le parole non meno che attraverso le fattezze che vanno assumendo. A volte, si prendono gioco dei mortali, altre volte si mostrano senza soverchi pudori.
L'universo di immagini, prodotte dalla lingua o dalla mano, in forma di verso o di pietra, metallo o pittura, sembrano suggerire la presenza di un doppio dell'esistenza umana, altrettanto provvisorio e caduco, e soprattutto, altrettanto proteiforme. Le figure non strettamente naturali, create dall'uomo o da qualche potenza sovrumana, venivano indicate con il termine eidola. Così raccolte in una categoria generale comprendevano diversi tipi di manifestazioni. Psychè, era l'anima di un defunto, altrimenti indicata con skià, ombra. Oneiros, invece, era l'apparizione in sogno, phasma, la manifestazione divina. Tra gli eidola trovava posto anche il manufatto carico di valenze simboliche e rituali: Vernant ricorda il kolossos, propriamente una statua (anche malamente abbozzata) che aveva la funzione di sostituire un defunto in un rito o in un cenotafio (4).
Achille vede l'eidolon di Patroclo evocato da un desiderio nostalgico. In sogno, l'eidolon di Elena rende ancor più insopportabile a Menelao l'assenza della sposa. Laodamia, invece, giunge a modellare un eidolon in cera del compagno scomparso, una statua a grandezza naturale che ama al suo posto. Gli dei mossi a pietà per quella sventurata le concederanno per un po' di tempo la psyché, cioè il fantasma, del defunto. Un crudele gioco di specchi: da un lato un corpo senz'anima e dall'altro un'anima senza corpo.
Il racconto sembra ricalcare, almeno in parte, la leggenda pliniana dell'invenzione della pittura: una fanciulla innamorata è triste per la partenza dell'amato. Ne ricalca su un muro l'ombra del viso proiettata dalla luce di una candela. Il padre, abile vasaio, scava il contorno tracciato per poi riempirlo di argilla fresca che servirà a costruire, appunto, un simulacro che nell'assenza, allevierà il dolore della giovane. Le origini dell'immagine, come nota Debray (5), sono nel tema dell'assenza e della morte. Aggiungiamo che quelle radici si alimentano della parola, istituendo una familiarità e al tempo stesso una antinomia con una lunga vita. La parola come ombra dello sguardo?
I Greci non conobbero alcuna interdizione all'immagine come accadeva presso gli Ebrei, anzi raffiguravano le proprie divinità in una grande varietà di atteggiamenti e condizioni. Decoravano e abbigliavano le loro statue, le rivestivano di metalli preziosi e di stoffe mirabilmente tessute. Per rendersele più simili, cospargevano la superficie di pietra levigata di una finissima cera colorata, affinché l'incarnato fosse ancor più vivo. Gli dei assumono forma di nubi, di cigni, di guerrieri; si lasciano spiare, imprecanti, afflitti, distratti, infiammati da ardori amorosi. Di pietra, gesso e pigmento sono le loro membra, ma umane fin troppo umane le loro fattezze e non sempre nobile il fine di tante trasformazioni.
In questo senso andrebbe riletto il mito di Aracne: la giovane tessitrice vanta senza posa le proprie abilità tanto che Pallade indispettita, sotto le spoglie di un'umile vecchia, le lancia una sfida. Le due si affrontano silenziose al telaio, ma nel racconto non è tanto narrato l'ennesimo caso di superbia umana prontamente punita, quanto il confronto tra le rappresentazioni scelte nei due manufatti tessuti nella competizione. La tela della dea è decorata con scene che esaltano la potenza degli dei. Quello della impertinente mortale, invece, rappresenta degli stessi dei i numerosi inganni e le mendaci sembianze assunte a danno degli uomini. A irritare la dea non è tanto l'abilità artigiana della giovane, quanto la sua capacità nel mettere in mostra i misfatti delle divinità, di fare cioè della rappresentazione uno strumento di smascheramento. Aracne vede sotto le apparenze e mostra nella sua tela che l'immagine è in grado di ingannare, ma anche di svelare più e meglio di quanto non facciano le parole.
Alla cultura greca siamo soliti attribuire l'invenzione della teoria. Teoria ha l'etimo in teorisco, guardare. La speculazione astratta, quella che assiste alla nascita della matematica, della geometria e della filosofia è infatti, più vicina alla contemplazione di un quadro concettuale che a un racconto. Anzi lo sviluppo dell'astrazione propria di quelle discipline è il progressivo liberarsi dai ceppi della narrazione verso una indagine propriamente visuale del mondo. Per uscire dal labirinto, due sole sono le possibilità: il filo di Arianna, lo strumento del ragionamento algoritmico e narrativo, della lenta ricerca che ripete i propri passi, oppure il volo di Dedalo, lo sguardo dall'alto e il colpo d'occhio (6). È questa l'invenzione del pensiero geometrico
Calcolo: in latino calculus, indicava il piccolo sasso di forma regolare, simile all'astragalo, con il quale si era soliti giocare ma anche fare di conto. La disposizione dei sassolini su un terreno piano, non più casualmente ma secondo un'ordine rigoroso, dovette suggerire la possibilità di istituire tra essi reciproci rapporti di distanza e di posizione. Disposti secondo un disegno apparente i calculi individuavano triangoli, quadrati e poligoni che però stavano negli occhi e nella mente dell'osservatore: saper cogliere l'ordine che sosteneva ogni disposizione doveva essere una qualità dell'esperto geometra, almeno quanto il saper vedere il disegno di una costellazione per l'astronomo. Una leggenda attribuisce ai pitagorici l'invenzione del teorema (7). Anche questo termine deriva da teorisco che indica l'atto dell'essere spettatori, e sta a indicare un insieme di argomenti organizzati in una successione tale da condurre a una evidenza. Possiamo immaginare l'accolita pitagorica mentre osserva lo spettacolo nuovo delle figure geometriche le cui proprietà sono dimostrate grazie alla parola, ma che si rivelano attraverso il disegno e l'immagine. Per i pitagorici, perciò, i numeri avevano qualità visive. Ci dicono, infatti, di numeri triangolari e di numeri oblunghi. La geometria media il rapporto tra sensibile e intellegibile e intorno a una figura, alla linea sottilissima del suo profilo, si svolge il lavoro dell'artista che impara a riconoscere le forme delle cose, essenza delle cose stesse. In questa abilità è, come si è visto, riposta l'origine stessa del disegno e della scultura.
La filosofia, nel pensiero greco, condivide della geometria, una analoga necessità di sistematizzazione. Il pensiero, in quanto esercizio della ricerca della verità, si laicizza nella messa in scena. "Teoria", come "teorema", ha a che fare con lo spettacolo (8). Il sapere, dunque, come teatro? Il processo della conoscenza è spesso sublimato nella tragedia che dispiega eventi che rendono evidenti agli astanti i destini dei protagonisti, prima disseminati negli intrecci delle vicende. Lo spettatore della tragedia solitamente conosce fin dall'inizio trama ed epilogo, ma segue ogni volta con immutato interesse i percorsi attraverso i quali il vero finisce per mostrarsi ai protagonisti inconsapevoli. Nella inevitabilità degli accadimenti, l'evidenza infine si mostra sulla scena, davanti agli occhi di tutti, attraverso e per mezzo dei molti equivoci, spesso generati dall'ambiguità delle parole. Edipo è l'interprete della tragedia della conoscenza. L'unica azione che accade sul palcoscenico è quella della ricerca del verità. Egli deve sapere. Ma sapere è vedere e la verità assoluta acceca. Per questo Edipo porta in scena la tragedia dello sguardo.
Il dialogo tra Edipo e Tiresia istituisce una perfetta simmetria: Tiresia conosce la verità ed è cieco, Edipo è in grado di vedere, ma non sa. Quando anch'egli saprà, si accecherà, diventando, nella seconda tragedia sofoclea, un veggente simile a Tiresia. Dunque, Dio non agisce apertamente come voleva Giocasta, è necessario, che le sue volontà emergano, siano apparenti, per mezzo delle dolorose disavventure degli uomini ed è necessario che questi, attraverso la sofferenza, giungano a veder chiaro il disegno predisposto dal fato. Muthos, prima ancora che racconto e mito, è la trama, la tessitura delle vicicissitudini, la tela tessuta dal tempo. È il filo invisibile che lega gli eventi in una disposizione assegnata, così come i calculi nello schema della figura geometrica. Nella tragedia l'orditura che si nasconde dietro ogni biografia si dipana fino a rendere insufficienti le parole del racconto. Edipo, terribilmente deturpato, si mostra al coro che ammutolisce: io non riesco a guardarti. Starti davanti è solo un lungo brivido.
Io amai anche la pittura ricoperta di cera, ricolma di pietà (Giovanni Crisostomo)
Debray fa risalire al concilio di Nicea una delle prime riflessioni circa lo statuto dell'immagine.
Alle radici del cristianesimo, sulle quali tradizione ebraica e quella della classicità greco-romana esercitarono una influenza determinante nella dialettica tra la parola e l'immagine, è rintracciabile una scelta definitiva per l'immagine come via privilegiata per la conoscenza e la fede. A Nicea, nel concilio del 787, le due tradizioni quella della parola e quella della figura, trovarono una nuova e inedita composizione. Con la campagna iconoclasta le raffigurazioni di Cristo e dei santi venivano asportate o distrutte perché dichiarate sacrileghe.
Con il concilio di Hiera (754), convocato a sostegno delle tesi iconoclaste, si era ribadito una asserzione dalle notevoli implicazioni: la rappresentazione partecipa sempre della natura del modello ed essendo vietato farsi un'immagine di Dio, deve essere evitato anche qualsiasi tentativo di raffigurazione. Al di là delle implicazioni storiche e religiose, il dettato iconoclasta apriva inedite questioni. Qual è la natura di un'immagine? Quale il statuto nell'attività di conoscenza e quale il rapporto tra un soggetto e le sue molteplici possibilità di raffigurazione? L'ambiguità di alcuni termini nella traduzione tra greco e latino non aiutava. Phisis in greco è propriamente il mondo fisico, in latino, tradotto come natura, assume un duplice significato: indica le caratteristiche generali immutabili di un individuo, ma anche, come in greco, il mondo sensibile nel suo insieme. Ousia viene tradotto, con non perfetta equivalenza, in "essenza" ed è assunto come corrispondente anche del termine ipostasi, che è letteralmente proprio ciò che è posto a fondamento. Prosopon indica l'aspetto e il volto, persona in senso grammaticale e deriva da pros-poieo, assumere una parte e indica la maschera della tragedia con un corrispettivo nel latino persona, che è il personaggio teatrale.
Un panorama linguistico tutt'altro che univoco, dove a concettualizzazioni già sottili rispondevano sottili sfumature di senso nel lessico utilizzato.
Quando la furia iconoclasta con il tempo parve affievolirsi, fu convocato a Nicea un nuovo concilio per ribadire la liceità delle immagini.
Gli atti del concilio sono illuminanti per diverse ragioni e rappresentano una ampia riflessione che si può ascrivere al dibattito estetico (9). Rappresentare il Cristo, sostengono gli iconofili, significa solo testimoniare la sua parola e il suo insegnamento e proprio questa possibilità distingue i cristiani dai giudei e dai pagani. La produzione di immagini non può portare all'adorazione di idoli poiché le immagini sono, se ben utilizzate, solo la testimonianza di una verità che a esse non appartiene e che è invece relativa a un'altra sfera di realtà. Può esistere un uso improprio dell'immagine e questo sì, va condannato. Nel concilio di Nicea viene, perciò, sottolineata una differenza. È avvalorata la doppia natura dell'immagine: essa può essere parto fantasioso della mente (e in ciò è esecrabile), ma può essere anche viva testimonianza di una verità e dunque va utilizzata ed esaltata. Può essere veritiera senza essere il Vero, ma a esso rimandare, come già è della parola. In ciò, è evidente una concezione platonica grazie alla quale, paradossalmente, l'immagine si dota di quel proprio autonomo statuto, che le assicurerà una lunga e feconda esistenza.
Platone, secondo Wunenburger (10), distingue una "mimesi icastica" (eikastike techne) che genera immagini-copie o icone (eikona) realmente omologhe ai loro modelli, da una "mimesi dell'apparenza" (phantastike) che fabbrica immagini che simulano una somiglianza e inducono all'illusione, gli eidola. Il giudizio di Paltone nei confronti delle arti è severo: le opere d'arte possono essere dannose perché in quanto simulacri esplicitamente tendono a ingannare i sensi attraverso le somiglianze oppure possono essere inutili immagini di immagini, copie degradate, in quanto ripetizioni al peggio, di una forma che è già il prodotto rappresentativo di un'idea. Tuttavia Platone riconosce nella generazione delle immagini una gerarchia: tra l'essere e le sue copie resiste una catena d'oro della somiglianza, ove il Medesimo si ripete dall'alto al basso dei livelli dell'essere.
L'immagine è legittima, si dice a Nicea, poiché innanzitutto testimonianza, ma anche perché somiglianza: il rapporto di filiazione, tra Padre e Figlio, tra Creato e uomo, ha bisogno di forme per essere colto e per dichiararsi agli occhi dell'incredulo o dell'incolto. Si apre con tali affermazioni un'epoca nuova: il Cristianesimo, accoglie e sviluppa l'eredità classica facendo della visione una via d'accesso alla salvezza e dell'immagine il veicolo più diretto della diffusione del credo. Non più l'orecchio, ma l'occhio è al centro dei processi di conoscenza, mentre alla rappresentazione è affidato un ruolo primario nello sviluppo della civiltà. In questa prospettiva, la recente civiltà dell'immagine, avrebbe ben altre dimensioni temporali, tutte ancora da misurare.
Domenico Papa
NOTE
1) Gershom Scholem, Il Nome di Dio e la teoria cabbalistica del linguaggio, Adelphi, 1998.
2) Clarisse Herrenschmidt, L'invenzione della scrittura, Jaca Book, 1999.
3) Ibidem, p.75.
4) Jean-Pierre Vernant, Mito e pensiero presso i Greci, Einaudi 1978, p. 348.
5) Régis Debray, Vita e morte dell'immagine, Il castoro, 1999.
6) Michel Serres, Le origini della geometria, Feltrinelli, 1993.
7) Carl B. Boyer, Storia della matematica, Mondadori, 1980.
8) Domenico Papa, Origini della distanza, Masoero, 1998.
9) (A cura di) Luigi Russo, Vedere l'invisibile. Nicea e lo statuto dell'immagine, Aesthetica,1997.
10) Jean-Jacques Wunenburger, Filosofia delle immagini, Einaudi 1999, p.148.


